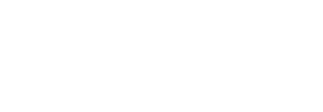Con l’ordinanza n. 6562 del 2 aprile 2025, il TAR Lazio, Sezione IV-ter, ha sollevato rilevanti questioni interpretative in materia di esclusione automatica dalle gare pubbliche e applicabilità dell’istituto del self-cleaning, nel contesto dei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI). I profili critici rilevati dal Tribunale amministrativo concernono la compatibilità della normativa nazionale – specificamente dell’art. 94, comma 6, del D.lgs. 36/2023 – con il diritto europeo, sollecitando un pronunciamento chiarificatore della Corte di giustizia dell’Unione europea.
L’ordinanza prende le mosse da una vicenda concreta, riguardante l’esclusione di un RTI risultato primo in graduatoria per l’aggiudicazione di tre lotti in una procedura bandita da RFI. La causa dell’esclusione è individuata nella presenza di tre violazioni tributarie definitive in capo a una mandante (SUB SERVICE S.r.l.), che superavano la soglia di rilevanza prevista dall’allegato II.10 del Codice. Il TAR evidenzia come tali violazioni, ancorché successivamente estinte prima dell’esclusione, non abbiano consentito il ricorso al self-cleaning in quanto l’estinzione era avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Il Collegio censura proprio questo automatismo normativo, ritenendo che lo stesso non trovi fondamento nella disciplina unionale, e che imponga una lettura più conforme ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell’affidamento. affronta, con particolare ampiezza e rigore argomentativo, delicate questioni interpretative relative al regime delle cause di esclusione automatica di cui all’art. 94, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e all’applicabilità del self-cleaning nei raggruppamenti temporanei d’imprese (RTI).
1. Il limite temporale del pagamento dei debiti tributari
Secondo il TAR Lazio, l’articolo 94, comma 6, del D.lgs. 36/2023, che impone il pagamento o l’impegno vincolante a pagare il debito fiscale prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, a pena di esclusione e senza possibilità di sanatoria in corso di garra, appare contrastare con il diritto eurounitario, in particolare con gli articoli 57 della direttiva 2014/24/UE e 80 della direttiva 2014/25/UE, e con il principio di proporzionalità.
Ciò in quanto il limite temporale in questione non è previsto dalle direttive né, tantomeno, può considerarsi ragionevole, non essendo «giustificato da apprezzabili ragioni».
L’assenza di un limite temporale emerge già dalla lettura del considerando n. 100 della direttiva 2014/24/UE, pur affermando che il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali debba condurre all’esclusione, non introduce un termine rigido come quello italiano.
Ciò è confermato anche dall’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE, per il quale l’esclusione <<non è più applicabile quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe» e dal suo testo. In nessuna parte sono introdotti sbarramenti temporali rigidi per l’adozione di queste misure.
D’altronde, questa secondo il TAR è l’unica interpretazione ammissibile della disciplina eurounitaria, pena altrimenti la violazione del principio di proporzionalità (e, si può aggiungere, del principio di ragionevolezza). La disciplina europea consente infatti di sanare cause di esclusione consistenti nella commissione di gravi reati, e di sanarle anche in corso di procedura. Consentirlo per queste ipotesi, ed escluderlo invece per omessi pagamenti che possono trovare cause differenti e anche incolpevoli, <<si porrebbe in evidente contrasto con il principio di proporzionalità, di matrice eurounitaria>>.
La conoscenza della causa escludente e l’estromissione del mandante
Il TAR Lazio solleva dubbi di compatibilità con il diritto eurounitario in merito anche a due previsioni contenute nell’art. 97 del Codice dei contratti pubblici, che prevedono:
- da un lato, l’obbligo per il raggruppamento di comunicare, già in sede di offerta, l’eventuale esistenza di una causa escludente relativa a uno dei suoi componenti, anche qualora quest’ultimo abbia attestato nel DGUE la propria regolarità fiscale;
- dall’altro, l’obbligo di estromettere o sostituire tale soggetto prima ancora che la stazione appaltante abbia comunicato la sussistenza della causa escludente.
Le due prescrizioni si fondano su una presunzione assoluta di conoscenza interna al raggruppamento, valorizzata dalla giurisprudenza nazionale (Cons. St., sez. V, 2 agosto 2024, n. 6944), secondo cui i componenti del RTI sarebbero tenuti a conoscere la situazione degli altri. Tale impostazione, secondo il TAR, si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, nella misura in cui impone un’esclusione automatica anche in assenza di una conoscenza effettiva.
Il Collegio richiama in senso contrario la sentenza della Corte di Giustizia, causa C-210/21, secondo cui «l’art. 63 della direttiva 2014/24/UE, in combinato disposto con l’art. 57, par. 4, lett. h), e alla luce del principio di proporzionalità, osta a una normativa nazionale (…) che imponga l’esclusione automatica dell’offerente per fatti riferibili all’impresa ausiliaria, senza consentirne la sostituzione». Principi, questi, che si ritengono applicabili anche ai raggruppamenti e consorzi.
Ne deriva che:
- l’eventuale dichiarazione inveritiera resa da un componente non può automaticamente travolgere l’intero RTI, salvo che non emerga una conoscenza effettiva da parte della mandataria;
- la sostituzione o estromissione del componente colpito da causa di esclusione deve potersi attivare anche dopo la presentazione dell’offerta, e non esclusivamente in via preventiva.
In conclusione, «la necessità di “prevenire” la stazione appaltante costituisce un limite non proporzionato rispetto all’obiettivo di assicurare che la commessa pubblica sia ottenuta dal miglior offerente e non congruente con la sua natura, pena la trasformazione dell’istituto del self cleaning (…) in una sorta di leniency programme» nonché l’instaurazione di forme di responsabilità oggettiva (per fatto altrui) anche in assenza, quantomeno, di colpa del soggetto (come accade per l’avvalimento, dove l’omessa conoscenza è imputabile solo per colpa o dolo).
Conclusioni e spunti di riflessione
Questa ordinanza solleva questioni centrali e potenzialmente dirompenti per l’attuale assetto normativo italiano in materia di appalti. I dubbi espressi, rigorosamente fondati su principi europei consolidati, aprono a possibili rilevanti modifiche interpretative che potrebbero ristabilire una maggiore proporzionalità e razionalità nella gestione delle esclusioni dalle procedure di gara, riequilibrando il rapporto tra efficienza amministrativa, tutela della concorrenza e libertà d’impresa.
A rendere ancora più incerta la tenuta dell’automatismo espulsivo per violazioni tributarie concorre il fatto che la medesima disciplina è oggetto di un’ordinanza di rimessione[1] alla Corte costituzionale, che dovrà pronunciarsi sulla sua conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento interno. La norma, dunque, naviga attualmente tra due mine: il giudizio pregiudiziale europeo e il vaglio costituzionale interno, con il rischio che entrambi ne impongano una profonda revisione.
Sarà decisivo attendere la risposta della Corte di Giustizia dell’UE, nonché l’esito del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per comprendere se l’attuale quadro normativo nazionale sia destinato a evolvere significativamente, ampliando in modo coerente ed equo il perimetro applicativo del self-cleaning, in armonia con il diritto europeo e con i principi fondamentali della Costituzione.
___________
[1] Cons. Stato, ordinanza 11.9.2024 n. 7518.